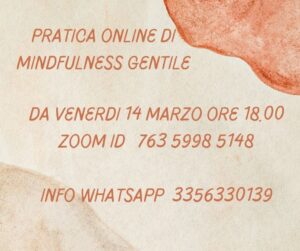Allo scopo di tracciare brevemente una cornice di riferimento teorica, saranno prese in esame quattro correnti, una psicosociale, l’altra socio-cognitiva, la socio-culturale e la contestualista.
Il primo orientamento concettuale si riferisce alla teoria dell’apprendimento sociale (Bandura, 1974), all’interno dell’approccio socio-culturale alla psicologia dell’educazione. Secondo tale modello, la maggior parte della condotta umana è originata indirettamente, dall’osservazione, e in seguito dall’imitazione (modellamento) delle azioni compiute da un altro soggetto. La sua efficacia dipende, secondo Bandura, da alcuni aspetti: l’attenzione, il rinforzo, la conservazione in memoria dell’evento, la capacità di esecuzione motoria. In situazioni di piccolo gruppo, è probabile che un individuo che si mostri in grado di fornire prestazioni nuove, o di complessità superiore, sia imitato da chi al momento è capace di prestazioni inferiori.
Ciò è rilevato anche nell’ambito degli studi sulle situazioni di condivisione di interessi e di competenze specifiche, in cui i partecipanti interagiscono progressivamente, affidandosi e identificandosi nelle relazioni di gruppo; inoltre, viene riconosciuto un ruolo all’imitazione graduale (partecipazione periferica legittimata) dove, dopo un intervallo di tempo nel quale si osserva il lavoro degli esperti, il novizio procede verso un’adesione alle pratiche centrali della comunità.
Una seconda corrente di pensiero fa capo a uno dei maggiori teorici dell’educazione, Jean Piaget (1952). Tra gli innumerevoli contributi prodotti a seguito del suo lavoro, evidenziamo i meccanismi che sono alla base dell’apprendimento collaborativo, caratterizzato da una motivazione collettiva basata su identità condivisa e costruzione di senso, nello svolgimento di un compito. L’evoluzione cognitiva, secondo Piaget, si svolge in conformità a progressive ristrutturazioni di schemi cognitivi di approccio all’esperienza, favorendo un graduale decentramento rispetto alla posizione in cui il punto di vista è esclusivo (egocentrismo), cercando poi nei dati esterni le conferme a tali convincimenti, e applicando gli schemi mentali alla realtà (assimilazione). Di tanto in tanto, tali schemi si mostrano in chiaro conflitto con il mondo, dando origine a situazioni di tensione e di crisi cognitive, sia a livello individuale, sia sociale, che possono sfociare in una ristrutturazione degli stessi schemi (accomodamento). Sempre nell’ambito della prospettiva cognitiva, anche la teoria della dissonanza cognitiva di Festinger sostiene il ruolo fondamentale, nelle fasi dell’apprendimento, della crisi nelle coordinazioni cognitive, evidenziando i processi dinamici, di squilibrio e revisione, che avvengono in momenti di discrepanza di senso o di dissidio nelle interazioni sociali.
In questi approcci, si evidenzia il ruolo dell’interazione tra posizioni differenti, che possono spingere a sviluppare la capacità di negoziazione tra punti di vista, e in seguito di una loro revisione. Il punto di vista soggettivo non potrà essere l’unico, e il rapporto sociale potrà evidenziare un conflitto, dovuto alla difficoltà ad abbandonare la sicurezza delle posizioni iniziali. Va rilevato inoltre che non è sempre necessario che avvengano ristrutturazioni rilevanti di pensiero. Infatti, gran parte degli apprendimenti si compongono di riflessioni, integrazioni, aggiustamenti e modificazioni parziali, in conformità a credenze culturali e conoscenze precedenti.
A tutto ciò va aggiunto che, per caratterizzare cognitivamente la capacità di apprendimento, la motivazione ad acquisire strumenti utili e a porsi attivamente di fronte ai problemi, assumendosi la responsabilità delle decisioni, si deve far ricorso agli importanti concetti di auto-attribuzione e auto-efficacia (Bandura, 1974). Attribuire le cause di un fallimento a motivazioni interne e non permanenti, ma modificabili, contribuisce ad innalzare le capacità di perseverare, riducendo stress e vulnerabilità psicologiche. La percezione dell’efficacia personale è naturalmente influenzata sia dalle esperienze personali, sia dalle relazioni sociali, e può essere coltivata nel confronto con persone che si considerano simili a sé e che riescono a raggiungere buoni risultati, oppure verificando l’adeguatezza dei propri mezzi rispetto ai criteri imposti dalla situazione.
A questo proposito, dall’opera di Lev Vygotskij (1974) è possibile estrarre un contributo sulla comprensione degli aspetti socioculturali dell’apprendimento, visto come un processo d’internalizzazione, della storicità delle funzioni psichiche e del linguaggio, per giungere poi ai processi individuali e del pensiero. Secondo lo psicologo sovietico, concetti e nozioni, oggetto di dialogo, sono progressivamente integrati nelle strutture cognitive dell’individuo attraverso la riflessività e il monologo interno. Al contempo, tali meccanismi possono anche essere reinterpretati, nel senso che il soggetto meno esperto se ne appropria, ripresentando in seguito una diversa interpretazione, che arricchisce il gruppo sociale nel suo complesso.
In tempi più recenti, il filone contestualista e della cognizione situata e condivisa ha posto l’enfasi sull’ambiente sociale e fisico dell’apprendimento, più che sui contributi individuali, per cui i processi cognitivi connessi vanno considerati includendo il contesto in cui si generano. Lo scenario è parte integrante del processo di apprendimento “in situazione”, creativo e, allo stesso tempo, rappresentato socialmente. In tale prospettiva, il costrutto di gruppo è essenziale, e l’apprendimento avviene principalmente in relazione, grazie a forme di negoziazione sociale, e non attraverso la trasmissione di pratiche cristallizzate nel tempo e poco interconnesse. Gli ambienti dovrebbero fornire differenti rappresentazioni della realtà, restituendo la naturale complessità del mondo, in un processo di costruzione attiva della conoscenza. L’apprendimento collaborativo è considerato un processo di costruzione di una rappresentazione comune, in un clima sociale ed emozionale condiviso, in cui si alimentano azioni auto-riflessive, prendendo stimolo da casi e da problemi concreti (meta-apprendimento) e contestualizzati (apprendimento come processo situato).
Soprattutto in ambito lavorativo, l’attività di auto-regolazione, che comprende le strategie di attenzione, pianificazione, auto-monitoraggio, auto-valutazione e auto-rinforzo, è un elemento fondamentale del “saper apprendere” (De Vita, 2007), che consiste nel mettere ordine nell’enorme quantità di informazioni disponibili ogni momento, ponendosi obiettivi più definiti e aggiungendo elementi di valutazione. Le persone possono tendere a imparare il modo in cui imparano, possono vedere le connessioni in contesti apparentemente scollegati e sanno porre in opera alcune condizioni che permettono di imparare meglio (apprendimento intenzionale).
Infine, interessanti spunti si possono trovare anche nella visione della cognizione distribuita (Jézégou, 2013), in cui l’intelligenza non è vista una proprietà dell’individuo, ma si può collocare anche nel mondo, dove si ritiene si formino i saperi e le memorie condivise, in modalità complesse e variegate.
Il rapido sviluppo in corso nell’ambito del social networking mostra le notevoli possibilità offerte da tale ambiente per lo studio e il lavoro in un clima di operatività e in un contesto aperto e informale, centrato su autentiche esigenze conoscitive ed espressive (Petti, 2011). I relativi strumenti e applicazioni si caratterizzano in modo flessibile, dal punto di vista degli utenti, cercando di porsi in contiguità con gli interessi e le esigenze personali, e suggerendo modalità nuove di costruzione della conoscenza condivisa.
L’instaurarsi di reti comunicative e relazionali è un elemento cruciale per l’apprendimento. A tal proposito, Siemens (2004) propone il concetto di connettivismo, per indicare una nuova modalità di apprendere, tipica dell’era digitale, in cui la rete stessa dà forma ai processi di apprendimento. Questa prospettiva teorica originale pone l’attenzione sulle connessioni costruite gradualmente, che rendono possibile e fruibile l’accesso alla conoscenza, e sull’abilità a riconoscere connessioni in ambiti diversi, al fine di mantenere una conoscenza accurata e aggiornata. Riguardo alle attività di gestione dei processi di conoscenza, il paradigma del connettivismo, che si pone come un’integrazione dei principi esplorati dalle teorie del caos e della complessità, dall’auto-organizzazione e dalle topologie di rete, può sostenere le nuove sfide nell’ambito aziendale e delle organizzazioni. La conoscenza che risiede in una base di dati richiede di essere connessa con le persone e le entità giuste nell’intreccio opportuno, al fine di trasformarsi in apprendimento. Da questo punto di vista, la capacità di collegarsi a fonti informative e reti sociali attraverso le tecnologie digitali è ritenuta più importante della conoscenza che può essere acquisita personalmente. Apprendere significa in definitiva essere connessi, mentre il cognitivismo e il costruttivismo, presupponendo elevate capacità di autonomia decisionale del discente, non vengono ritenuti in grado di dare il necessario supporto teorico alle sfide riguardanti l’organizzazione e il trasferimento della conoscenza in ambito professionale e lavorativo (Siemens, 2004).
 La crescita è un processo continuo nel quale si tende senza sosta a livelli più grandi di appartenenza e al tempo stesso di maggiore differenziazione […]. Quanto più abbiamo il coraggio di appartenere, tanto maggiore sarà la nostra libertà di essere indipendenti. Più è grande la nostra capacità di differenziarci, più saremo liberi di appartenere (Carl A. Whitaker)
La crescita è un processo continuo nel quale si tende senza sosta a livelli più grandi di appartenenza e al tempo stesso di maggiore differenziazione […]. Quanto più abbiamo il coraggio di appartenere, tanto maggiore sarà la nostra libertà di essere indipendenti. Più è grande la nostra capacità di differenziarci, più saremo liberi di appartenere (Carl A. Whitaker)